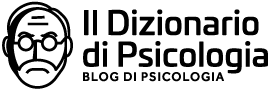È più importante essere o avere? Si può partire dall’assunto secondo cui l’utilità dell’esistenza umana può essere giustificata in virtù degli averi posseduti da una persona, ovvero che l’essenza dell’essere sia l’avere:
“Se uno non ha nulla, non è nulla.”[1]
Questo punto di partenza è stato affrontato dai più grandi pensatori sin dai tempi antichi, come viene riportato nel Vangelo secondo Luca:
«Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la propria vita per me, colui la salverà. Infatti, che giova all’uomo l’aver guadagnato il mondo intero, se poi ha perduto o rovinato se stesso?» Luca, IX, 24-25
L’interrogativo sull’essere o avere, assieme a quello sull’amore per la vita o amore per la morte, è l’eterno dilemma dell’esistenza umana.
L’origine dei termini
«Avere», da un punto di vista linguistico presenta un problema di fondo, ovvero in molte culture è espresso in termini di possesso:
“in ebraico « io ho » deve essere espresso mediante la forma indiretta jesh li (« è a me », è mio)”[1]
O meglio, molte lingue non hanno un equivalente della parola “avere”. Da un punto di vista socioculturale, questa mancanza si ritrova in quelle società che in passato non si sono propriamente sviluppate poiché il sistema politico, economico e sociale, non favoriva il concetto di “proprietà privata”, ma di proprietà funzionale. Il possesso non è proprio, ma, solo temporaneo, in virtù dell’uso.
« Essere », invece, è comunemente usato in tre diverse accezioni:
- Come copula. Ad esempio « sono bella/o », « sono alta/o »
- In forma passiva per indicare “l’oggetto di un’attività altrui”. Es. « sono battuto »
- Per esprimere il concetto di esistenza. “Essere”, nelle lingue indoeuropee, deriva dal latino esse (volg. *essĕre), la cui radice è es- e contiene la nozione di esistenza.
“Ha il significato di «avere esistenza, essere reperibile in realtà»”[1]
Da qui ne derivano due fondamentali modalità di relazionarsi verso se stessi e verso il mondo. La prima modalità esistenziale dell’avere si concretizza nel possesso. La seconda, la modalità esistenziale dell’essere, rimanda a ciò che è consistente, autentico e vero, alla vera natura, all’essenza di una persona o di una cosa, oltre ogni apparenza.
LEGGI ANCHE: L’amore è un arte: il pensiero di Fromm
I riferimenti poetici
Sono due i riferimenti poetici presi come esempio da Fromm, Alfred Tennyson, poeta inglese del XIX secolo, e Matsuo Basho, poeta giapponese del XVII secolo. Entrambi descrivono la reazione alla vista di un fiore durante una passeggiata. Analizziamo prima la poesia Fiore che spunti dal muro screpolato di Alfred Tennyson:
Fiore che spunti dal muro screpolato
Io ti colgo dalla fessura
Ti tengo qui, la radice e tutto, nella mia mano
Piccolo fiore – ma se potrò capire
ciò che sei, la radice e tutto, e tutto in tutto,
saprò che cosa sono Dio e l’uomo.
(Alfred Lord Tennyson e Christopher Ricks, Selected Poems: Tennyson, 2007)
La seconda, di Basho, è un componimento poetico nato in Giappone nel XVII secolo che prende il nome di haiku.
Quando guardo attentamente
vedo il nazuna che fiorisce
sull’orlo della siepe.
(Matsuo Bashô e M. Muramatsu, Poesie. Haiku e scritti poetici, 1997)
Tennyson esprime l’essenza dell’essere con l’avere. Il fiore viene strappato con tutte le sue radici e di conseguenza viene distrutto per fare strada alla conoscenza, al metodo scientifico, ovvero la ricerca della verità mediante la disgregazione. Al contrario, Basho non si limita solo a guardare semplicemente il fiore, ma vuole essere “tutt’uno con esso”, cedere il passo all’identificazione e preservarlo dalla distruzione. In questo modo non si ha nessuna pretesa di avere, ma si vuole semplicemente essere accompagnati nel proprio cammino dalla gioia della vista di un fiore.
LEGGI ANCHE: Il sistema immunitario della psiche: la resilienza
Guadagnare il mondo intero, ma perdere se stessi
Il possesso è la questione centrale dell’avere, ma ha una valenza mutevole in quanto strettamente dipendente dal valore di cui è investito il bene/oggetto:
«Possedere un bene non serve a niente se non si è pronti a perderlo. E i beni la cui perdita è più facilmente tollerabile sono quelli che, perduti, non possono essere oggetto di rimpianto.» Seneca, Lettere a Lucilio, 1974 [2]
Il seguente passo di Giovanni Verga tratto da La Roba (1880), non solo esprime la funzione del possesso, ma allo stesso tempo delinea uno scenario ancora più drammatico, la vita non vissuta:
“La gente lo invidiava, ma «non sapeva quel che ci era voluto ad acchiappare quella fortuna: quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina di mulino, per fare la roba». Il tempo passa inesorabile anche per Mazzarò, la vecchiaia incombe segnando sempre più la sua solitaria lamentela: «Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla!». Quando Mazzarò si ammala e i medici gli comunicano che ha poco tempo da vivere, furioso ammazza «le sue anitre e i suoi tacchini», gridando: «Roba mia, vientene con me». Il suo cuore è più che indurito, è come cosificato, divenuto della stessa sostanza della roba. È proprio vero, come affermava il grande san Tommaso, che la vita dell’uomo consiste dell’affetto che maggiormente lo sostiene. Mazzarò non è triste, ma arrabbiato con gli altri e con la vita. Lui che non ha conosciuto altra legge che il possesso non ha nostalgia o rimpianto, non è cosciente di non aver vissuto e di non aver guardato in faccia la realtà. Manca in lui qualsiasi consapevolezza che la vita è domanda, ricerca e viaggio verso un destino.” Giovanni Verga, La roba, 1880 [3]
Se la vita non è stata vissuta, non c’è presente ne passato:
“Il passato non è morto e sepolto. In realtà non è neppure passato.” William Faulkner
Riferimenti:
[1] Erich Fromm, Avere o essere? (1976)
[2] Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio, 62/65
[3]Giovanni Verga, La Roba,1880
Immagine di copertina: William Hogarth, La carriera del libertino: la taverna, 1735